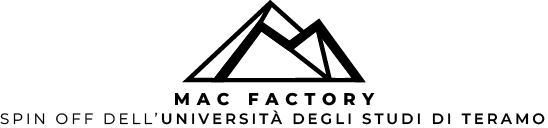Con la legge regionale 70/2 del 5 luglio 2022,l’Abruzzo ha modificato stemma e gonfalone, un cambiamento di cui si è parlato molto sui social in questi giorni. Ironia e polemica sono state, come sempre, le cifre del dibattito nella sfera pubblica social: ma la discussione – anche accesa – è il segnale che questo cambiamento non è sentito solo come un restyling grafico.
Con la legge regionale 70/2 del 5 luglio 2022,l’Abruzzo ha modificato stemma e gonfalone, un cambiamento di cui si è parlato molto sui social in questi giorni. Ironia e polemica sono state, come sempre, le cifre del dibattito nella sfera pubblica social: ma la discussione – anche accesa – è il segnale che questo cambiamento non è sentito solo come un restyling grafico.
E visto che MacFactory, oltre che come un’agenzia per la comunicazione culturale, si pensa anche come un’agenzia per il cambiamento culturale, abbiamo voluto provare a riflettere sulla questione in questo articolo perché modificare uno stemma regionale significa ritoccare un’identità collettiva.
Lo facciamo con due interventi: il primo è di Francesca Fausta Gallo, che insegna Storia moderna all’Università di Teramo e che ha studiato molto l’Abruzzo, riflettendo inevitabilmente sulla sua identità; il secondo è di Antonello Santarelli, che insegna Tecniche Grafiche Speciali all’Accademia di Belle Arti de L’Aquila, il quale analizza il nuovo stemma dal punto di grafico.
Una questione di identità
di Francesca Fausta Gallo (docente di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Teramo)
Nella Iconologia di Cesare Ripa, vasto repertorio di immagini allegoriche stampato per la prima volta nel 1593, l’Abruzzo era rappresentato come una “donna dall’aspetto virile e robusto, vestita di colore verde” che sta in un luogo “erto e montuoso” con vicino un cavallo e che tiene in una mano un’asta e nell’altra una cesta piena di zafferano.

Il Ripa, per rappresentare l’Abruzzo, attingeva ad elementi naturalistici e a due delle attività economiche prevalenti del territorio; non sentiva l’esigenza di guardare al passato e alla storia per trovare simboli univoci e identificativi.
In realtà, cercare nel passato oggetti, strumenti, personaggi che possano rappresentare “unitariamente” una regione, è un’operazione piuttosto rischiosa che può dar luogo a distorsioni palesemente anti-storiche, a partire dall’idea stessa di regione.
L’Abruzzo, ad esempio, in epoca pre-romana fu popolato da un numero consistente di popolazioni – Piceni, Equi, Marsi, Vestini, Peligni, Frentani, Marrucini – che avevano tratti comuni ma anche spiccate differenze e che spesso erano in guerra tra loro.
Anche dopo la conquista romana il territorio fu diviso in due province, la V Picenum e la IV Samnium. Con gli Angioini, nel XIII secolo, il territorio fu diviso in Aprutium Ulteriore e Citeriore e così rimase per secoli tanto che, ancora nel ‘900, era comune utilizzare il termine Abruzzi.
La regione, quindi, si caratterizza per una molteplicità di aspetti territoriali, storici, economici, difficilmente riconducibili a unità.
Voler individuare nel guerriero di Capestrano il nuovo simbolo da inserire nel gonfalone, capace di rappresentare unitariamente “nella storia” l’intera regione, è una scelta politica ed ideologica che mira a “costruire” dall’alto un’identità posticcia volta ad enfatizzare le specificità del “popolo” abruzzese nei confronti delle altre realtà regionali.
Una procedura probabilmente legittima sul piano formale, ma che si fonda su un distorto utilizzo del passato.
Il nuovo stemma della Regione Abruzzo: un’occasione sprecata
di Antonello Santarelli (docente di Tecniche Grafiche Speciali presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila)
Un nuovo stemma per la Regione Abruzzo? Saranno stati risolti i problemi del vecchio? Corro a vedere, ma ciò che viene proposto non solo conferma i problemi precedenti ma ne aggiunge di nuovi.
Prima di entrare nella riflessione sugli aspetti tecnici qualche domanda mi viene in mente.
Disegniamo per rappresentarci nella nostra comunità, per visualizzare il senso di appartenenza? Disegniamo affinché ci possano riconoscere? Disegniamo per raccontare la nostra visione del futuro e in che modo intendiamo collocarci?
Sulla base di queste generali riflessioni l’uomo, “l’animale disegnante”[1] (così definito da Giancarlo Illiprandi in “Una grammatica ritrovata”), costruisce ad arte un sistema di segni cioè costruisce “artefatti” ovvero mette in atto un processo trasformativo intenzionale per rispondere ai quesiti: Chi sono? Qual è la mia comunità? Come mi vedono? Come voglio che mi vedano? Come ci rappresentiamo come comunità? Che storia raccontiamo ad altre comunità?
La questione di un segno rappresentativo è quindi complessa.
 Dagli iniziali stemmi dell’Abruzzo Ultra, con l’aquila bianca sopra tre monti d’oro, e dell’Abruzzo Citra, con la testa di cinghiale, si arriva, nel 1986, a quello con lo scudo sannitico caratterizzato dalle tre fasce trasversali: bianca, verde e azzurra.
Dagli iniziali stemmi dell’Abruzzo Ultra, con l’aquila bianca sopra tre monti d’oro, e dell’Abruzzo Citra, con la testa di cinghiale, si arriva, nel 1986, a quello con lo scudo sannitico caratterizzato dalle tre fasce trasversali: bianca, verde e azzurra.
Se gli iniziali stemmi avevano indubbiamente una relazione con il loro tempo e le relative simbologie, oggi ci dovremmo domandare quali siano le simbologie verso le quali la comunità si riconosce. Il punto di riflessione si dovrebbe quindi spostare sulla questione metodologica.
Non si tratta tanto di un problema di gusto, quanto, piuttosto, di un problema di oggettività. Come scrive Bruno Munari in “Design e comunicazione visiva”
… se l’immagine usata per un certo messaggio non è oggettiva ha molte meno possibilità di comunicazione visiva: occorre che l’immagine usata sia leggibile a tutti e per tutti nello stesso modo altrimenti non c’è comunicazione visiva, anzi non c’è affatto comunicazione: c’è confusione visiva[2].
L’indirizzo dato negli anni Ottanta va nel senso generale dell’araldica rivisto però in una chiave più contemporanea, pur con problemi di tipo tecnico che affronteremo successivamente, una chiave interpretativa che vede nella proposta odierna una sorta di giro di boa ritornando a stilemi precedenti con l’inserimento della corona e di due rami di ulivo e di quercia, questi ultimi probabilmente in riferimento all’emblema della Repubblica Italiana (simboli l’uno di forza e dignità del popolo italiano, l’altro di volontà di pace sia interna che verso le altre nazioni).

Se già nel 1948 il Governo Italiano si pose il problema di una forma che fosse contemporanea e riferita ai nuovi valori, non si comprende il passo indietro fatto oggi dalla Regione Abruzzo.
I sistemi linguistici vanno analizzati sia in un’ottica sincronica che diacronica. La lingua, e in questo i simboli non fanno eccezione, è non modificabile nel suo tempo ma si modifica nei tempi e qui la domanda su quali siano i simboli della contemporaneità torna nuovamente e richiede però risposte più scientifiche che non siano il risultato di una semplice sensazione o di un gusto personale.
Ogni segno identificativo tiene conto, inoltre, non solo del complesso simbologico ma anche dei supporti che lo dovranno ospitare. L’antica araldica veniva dipinta e/o ricamata e ogni volta l’artigiano provvedeva a riprodurre con la propria arte rispettando le figure e i colori, ma rifacendo ogni volta e adattando/adattandosi al supporto. Falcinelli, nel suo famoso testo “Critica portatile al Visual Design”, parla proprio della differenza fra arte, artigianato e design:
un artefatto di design non esiste in un originale, ma nelle sue copie. E non si tratta solo di una necessità produttiva, ma di un orizzonte estetico, funzionale e di senso[3].
Oggi il digitale ha aumentato gli spazi di riproduzione in maniera esponenziale e la questione della “riproducibilità” è diventata ancor più delicata, dobbiamo, quindi, qui obbligatoriamente tenere conto degli aspetti tecnici quale altra faccia inscindibile della stessa medaglia.
Il nostro segno identificativo dovrà poter essere riprodotto su carta, su schermo, su materiali plastici, su un oggetto, dovrà essere possibile ingrandirlo infinite volte o riprodurlo molto piccolo, fino a entrare nello spazio di una penna, mantenendo sempre una chiara leggibilità fra le parti
Gli aspetti tecnici sono quindi fondamentali per una corretta progettazione, un po’ come la struttura di un edificio. Già Alfred Hohenegger nel 1986 indicava alcuni principi generali fondamentali
…d) Ogni marchio dovrebbe essere riducibile, nella sua forma, al massimo (carta intestata-distintivo), mentre l’ingrandimento è sempre meno problematico. f) L’utilizzazione del marchio deve essere possibile in tutte le forme e su tutti i mezzi, siano essi bi – o tridimensionali, stampa su carta, su altri materiali come il legno, il metallo quale supporto, non sempre piatto. Si deve prestare per un’insegna luminosa, per una fusione in materiale plastico o metallo, ecc. g) Trasformato da positivo in negativo, il marchio non deve avere diminuita la sua espressività. Bisogna prevedere il possibile cambiamento totale della forma, rovesciando un positivo in un negativo, o viceversa. g) Il marchio deve essere progettato in bianco e nero (tenendo conto dei valori positivi e negativi). In un secondo tempo si può studiare una rappresentazione a colori; mai, però, deve avvenire l’inverso…[4].
Il segno grafico della Regione Abruzzo fatto negli anni Ottanta aveva tanti problemi tecnici. Intanto non era stato prima progettato in nero ma direttamente a colori, poi il corpo del segno che definiva lo scudo non era in rapporto con l’intera figura e il risultato era che, spesso, in riproduzione ridotta tendeva a scomparire. Non essendoci una definizione in nero (K100%) ci si è arrampicati sugli specchi per anni a cercare una soluzione. Come fare per rispettare la versione colore nella sua riduzione in nero? Ecco il primo errore: non bisogna cercare di ridurre a un solo colore, piuttosto partire dal nero (quale struttura) per poi arrivare al colore nei suoi vari metodi. Insomma, nonostante gli sforzi di uniformarlo, il risultato è stato che, più o meno, ognuno doveva trovare la soluzione meno invasiva.
Ciò che oggi vedo è una sovrapposizione di un’immagine a una struttura vettoriale e su questo sarebbe necessario fare una riflessione sulla liceità di utilizzo di tre linguaggi che hanno storie diverse: l’illustrazione, la grafica e la fotografia. La questione qui diventa molto complessa perché se gli esempi di contaminazione dei linguaggi nell’arte sono tanti, non altrettanto succede nello specifico della disciplina del design di marchi e loghi che ha regole specifiche.
Senza entrare nel merito estetico (inteso come disciplina dell’estetica) della fotografia del Guerriero di Capestrano o della Corona, la questione è che un segno deve essere ingrandito e ridotto un numero enorme di volte. È quindi un errore gravissimo utilizzare un’immagine a tono continuo, che è costituita da una mappa di pixel. Più ci saranno pixel più l’immagine verrà percepita come definita ma, proprio per questa sua caratteristica, perderà di qualità quando sarà ingrandita. Inoltre, quando la faremo molto piccola il risultato sarà di avere una macchia non ben distinguibile
Un corretto segno identificativo deve avere una struttura vettoriale, così da evitare la perdita di risoluzione e permettere la riproduzione attraverso tutte quelle tecniche di taglio che vengono realizzate con macchinari a calcolo numerico (ad esempio il prespaziato). Questo però non basta, perché gli elementi che costituiscono il nostro segno, oltre ad avere corretti rapporti dimensionali, dovranno essere composti come un puzzle in modo da essere selezionati o tagliati senza errori.

Si possono vedere marchi di tipo gestuale, organico, geometrico, ma la regola rimane sempre la stessa: armonia percentuale fra gli elementi, tecnologia vettoriale, struttura in nero, versioni cromatiche, applicazioni.

Guardiamo quello della Sapienza di Roma, ogni segno è equilibrato con gli altri e ogni elemento è staccato. Lo stesso per il segno del decennale del terremoto aquilano o per l’Hospice “Casa Margherita” o per la famosa azienda Amazon. Ognuno di questi ha forti percentuali di riducibilità, ottime riproducibilità e riconoscibilità.
Cosa succederà al nuovo stemma? Beh, facile predizione: lo troveremo in .png (che supporta la trasparenza), sarà, di volta in volta, inserito in una finestra che ne disegni il contorno generale e contestualizzato nei vari mezzi risulterà, il più delle volte, una macchia non ben distinguibile. Senza parlare di cosa succederà alla scritta “Gentium Vel Fortissimarum Italiae”.
Un’ultima cosa: i colori metallici (oro, argento, ecc.) sono usati solo come eccezione all’originale e non mi dilungo sul perché.
Infine, parafrasando il linguaggio degli chef oggi così diffuso, la ricetta metodologia per una questione così delicata dovrebbe essere composta da:
- una buona mescolanza di ricerca antropologica, sociologica e sui trascorsi artistici;
- una solida base tecnica;
- una spruzzata di visionarietà;
- una sapiente miscelazione degli ingredienti;
- un’assaggio sulla sua interpretabilità e versatilità;
- una presentazione per servirlo in maniera strutturata.
Purtroppo non vedo niente di tutto ciò… un’altra occasione sprecata che costerà 70.000 € (fonte RAI) e farà impazzire i poveri tecnici grafici, aprendo molto probabilmente a contenziosi per l’inevitabile cattiva qualità di riproduzione.
Una postilla personale, a chiusura di queste riflessioni.
Il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri ha sottolineato che il nuovo stemma – approvato all’unanimità – sarà
un simbolo identitario che faccia sentire tutti i cittadini delle province d’Abruzzo davvero uniti.
Queste parole mi hanno fatto venire in mente la riflessione di Costantino Felice sulla identità sfuggente della regione Abruzzo, con cui si chiudeva un importante, ancorché discusso, volume sull’Abruzzo della collana “Le Regioni” Einaudi pubblicato nel 2000. Cercare di rinforzare il simbolo identitario della regione sembra andare nella direzione di una conferma di questa debolezza: ma, per farlo, paradossalmente, si va a cercare un aggancio storico che non è affatto un segnale di unitarietà né di identità condivisa, come ricordava Gallo.
E però, a ben guardare, il guerriero di Capestrano è immediatamente riconoscibile, non solo per le sue caratteristiche proprie, ma anche perché è stato oggetto di molte tesi controverse, fino ad approdare in Rai, a Voyager, la trasmissione sui misteri.
Il dubbio che viene, allora, è che sia un simbolo d’Abruzzo al di là di ciò che simboleggia davvero: ovvero che sia un segno riconoscibile più nella logica del marketing che in termini di identità, che è qualcosa di stratificato e che si costruisce lentamente e che, soprattutto, non è mai univoca né uniforme.
Per uno strano cortocircuito mentale mi è venuto in mente che il Consiglio regionale è stato promotore lo scorso anno di una campagna intitolata Abruzzo che spettacolo! tutta incentrata proprio su alcuni elementi fortemente riconoscibili, da Rocca Calascio agli arrosticini: dietro non c’era, ovviamente, alcun rimando alla cultura agropastorale o all’organizzazione territoriale nata dalle varie dominazioni straniere, ma solo un gioco – che si voleva autoironico – su ciò che il turista avrebbe potuto trovare in Abruzzo. E, cambiando regione ma sempre grazie a quello strano cortocircuito, mi è venuto in mente un cartello sull’autostrada che invita a visitare Ascoli Piceno perché è la «città delle olive ascolane» e non per la sua splendida Piazza del Popolo, ad esempio.
Si tratta di corto circuiti, appunto, che non dicono nulla di certo e che accostano situazioni molto diverse. Ma che, nonostante ciò, mi fanno sorgere un dubbio: che l’identità sia scambiata con la riconoscibilità. Che essa non venga intesa come un comune sentire, un qualcosa che mette insieme tradizioni e progetto di sviluppo, ma che, invece, venga percepita come un marchio, un segno identificativo, un puro brand, con l’errata concezione, peraltro, che il segno grafico non sia anch’esso una rappresentazione di valori e di visione.
[1] R. Falcinelli, Critica portatile al visual design, Torino 2014, p. 4
[2] B. Munari, Design e comunicazione visiva, Roma-Bari 2022, p.13
[3] G. Illiprandi, Una grammatica ritrovata, Milano 2009, p.14
[4] A. Hohenegger, Graphic Design, estetica & funzione / tecnica & progettazione, Roma 1986, pp. 285-286