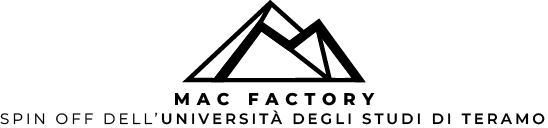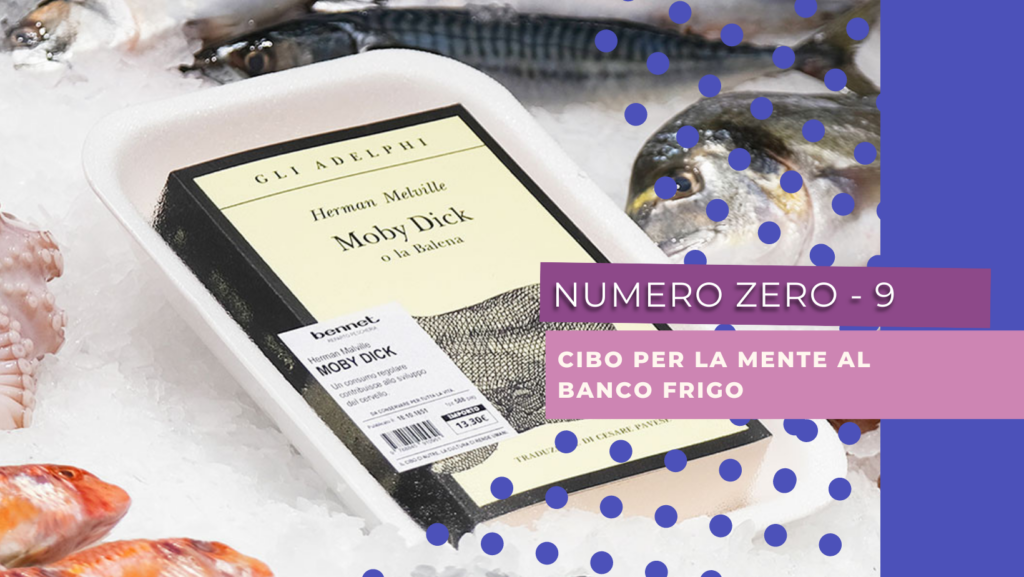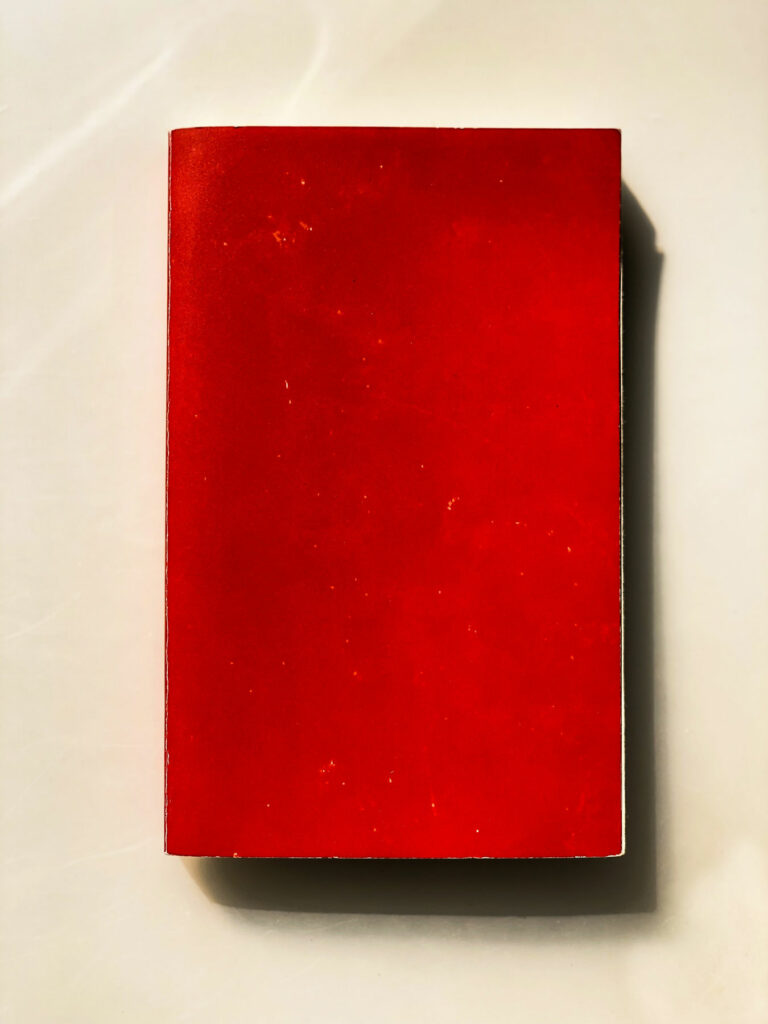Subito dopo la scomparsa di Oliviero Toscani, abbiamo chiesto a Marianna Boero, docente di Semiotica all’Università degli Studi di Teramo, dove tiene, tra gli altri, un corso in Semiotica della Pubblicità e del Consumo, una prima riflessione sul lavoro del fotografo e il suo contributo al cambiamento del rapporto tra fotografia e immagine commerciale. Ecco cosa ci ha scritto:
Provocatorie, scioccanti, irriverenti; ma anche acute, ingegnose, innovative. Sono diversi e contrastanti gli
aggettivi usati nel tempo per definire le campagne pubblicitarie di Olivero Toscani. Narrazioni “visionarie”,
sagaci, sempre in bilico tra provocazione e dissacrazione, in grado di trasformare il linguaggio visivo in una
potente forma di riflessione collettiva. Dalla pubblicità dei jeans Jesus degli anni Settanta, accompagnata
dal celebre slogan “Chi mi ama mi segua”, fino alla più recente campagna “No Anorexia”, con protagonista
Isabelle Caro, che denunciava implicitamente, attraverso un’immagine cruda e realistica, i modelli di
bellezza artefatti e utopistici imposti dai mass media, l’arte di Oliviero Toscani rappresenta una critica
consapevole al torpore e alla staticità che egli vedeva nella pubblicità tradizionale.
Tappa importante ancora oggi nello studio semiotico della pubblicità, le sue campagne per il marchio
Benetton non solo si sono distinte dalle pubblicità (soprattutto italiane) dell’epoca per aver segnato la fine
dell’ “happy ending” ma, soprattutto, hanno rappresentato il grande tentativo della pubblicità di invadere
nuovi territori discorsivi, trattando temi complessi, inediti, controversi. La pubblicità rompe il patto di
fiducia con il proprio pubblico, basato su valori positivi e sentimenti nobili, per abbracciare un pensiero
sociale più ampio, fatto anche di sofferenza e disperazione.
Come messo bene in evidenza da Andrea Semprini in uno studio del 1996, nelle sue pubblicità, Toscani ha
messo in scena il dolore, la differenza, la morte, facendo leva sulla “valorizzazione del negativo”, capace di
ribaltare il senso comune. Il discorso pubblicitario, tenta di riposizionarsi, di acquisire nuove aree di
legittimità, erodendo i confini di altri sistemi discorsivi, come quello medico, giornalistico, religioso, politico.
Ne deriva una ridefinizione dell’immaginario simbolico collettivo, con l’inizio dell’affievolimento della
distanza tra la pubblicità commerciale e la comunicazione sociale.